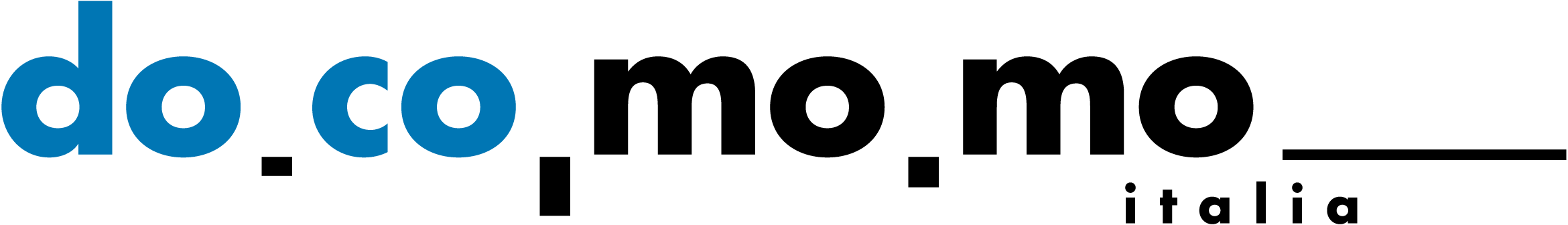di Ugo Carughi
Il patrimonio architettonico del Novecento appare indubbiamente trascurato dalla legislazione italiana di tutela, in totale controtendenza rispetto agli orientamenti della storiografia di settore. Con il risultato che architetture di grande rilievo sotto il profilo tecnologico e espressivo, oltre che storico e identitario, sono prive di tutela e, per di più, considerate alla stregua dell’edilizia corrente per qualsiasi intervento successivo alla loro realizzazione, compreso l’adeguamento ai requisiti di conformità.
L’esigenza di tutela dell’architettura del Novecento
Se siamo convinti che la conoscenza dell’architettura più recente costituisca un percorso irrinunciabile per comprendere ciò che ci accade attorno, si prospetta l’opportunità, ma meglio sarebbe dire la necessi- tà, di ricorrere a strumenti integrativi di valutazione e tutela adeguati alle problematiche poste, in particolare, dall’architettura del secondo Novecento, considerando che alcune di tali problematiche investono anche i meccanismi della tutela tout court. La natura di tali strumenti può esse- re attiva o passiva, assegnando la prima qualifica a programmi d’intervento e di gestione propedeutici al progetto, tra cui i cosiddetti Piani di conservazione; la seconda a nor- me integrative del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Va detto, in ogni caso, che non si dà strumento attivo di tutela che non sia integrato da normative coerenti, dettate da una chiara intenzionalità strategica. Pertanto, oltre che sullo strumento del Piano di conservazione, ci soffermeremo sulla possibilità di contemplare all’interno del Codice una norma che guardi an- che all’architettura più recente con intenti di tutela che garantiscano i diritti delle future generazioni.
Il Piano di conservazione
Rispetto alla normativa italiana, come a quelle d’altre nazioni, il Piano di conservazione va considerato uno strumento attivo e innovativo. In Italia occuperebbe un gradino intermedio tra la “dichiarazione di interesse culturale” e il “progetto di recupero e restauro”. La prima si limita a indicare le motivazioni storiche e critiche per le quali il bene va tutelato; non fornisce, generalmente, indicazioni operative. Queste ultime sono rinviate al momento in cui si interviene sull’opera e riguardano il progetto che, in assenza di orientamenti preliminari, può risentire dei condizionamenti derivanti dalle singole situazioni e dalla discrezionalità degli organi istituzionali. Il Piano di conservazione va, dunque, considerato un’importante opportunità per ovviare, almeno in parte, ai ritardi e alle rigidezze della normativa italiana del settore. La Carta di Cracovia, promulgata dalla Comunità europea nel 2000 con il titolo Principi per la conservazione e il restauro del patrimonio costruito, definisce la conservazione come «insieme delle attitudini della collettività volte a far durare nel tempo il patrimonio e i suoi monumenti». In questi Principi, esplicitamente riferiti alla Carta di Venezia, il Piano di conservazione viene definito come strumento preliminare al progetto di restauro e in grado, assieme ad altre decisioni collegate, di gestire il «continuo processo di cambiamento» nel quale incorrono i patrimoni architettonici. Il paesaggio, non più confinato nel ruolo di “contesto” o in quello di “giardini e parchi che vengono considerati di particolare importanza” (Carta del restauro 1972), diventa testimone del «rapporto evolutivo della società e degli individui con il loro ambiente». Dall’alto in basso: Pier Luigi Nervi, aviorimesse in cemento armato, Orvieto, Orbetello e Torre del Lago (1935-1942); magazzini, Margherita di Savoia (1933-36 e 1945-55); salone B, Torino (1947-49); magazzini del sale, Tortona (1949-51) Courtesy Fondation PLN Project.
Una riflessione sui Piani di conservazione finora formulati potrebbe, oltretutto, risultare utile a individuarne gli aspetti comuni e quelli inediti, con l’obiettivo di definire dei format utili per la redazione dei piani successivi, in una sorta di work in progress volto a perfezionare metodi e criteri di programmazione per architetture riconosciute degne d’interesse. La revisione della normativa di tutela Tuttavia, il Piano di conservazione da solo non sarebbe sufficiente a garantire un’attenzione efficace per l’architettura più recente di cui, appunto, è necessario preliminarmente riconoscere il possibile interesse. Quest’ultima operazione, tanto più delicata quanto più l’architettura è recente, più che riproporre una dichiarazione d’interesse culturale tassabile di opinabilità, dovrebbe almeno assicurare un’adeguata salvaguardia in attesa di un’eventuale iscrizione dell’opera al patrimonio. Una salvaguardia che tenga conto delle progressive esigenze di aggiornamento, proprie di ogni architettura, evitando operazioni di snaturamento e seguendo le linee guida d’intervento e di gestione in progress dettate dal Piano di conservazione. Il nodo centrale è costituito dal tempo che le normative di alcuni paesi interpongono tra la realizzazione di un’architettura e il giudizio istituzionale che se ne dà in funzione di un conseguente provvedimento di tutela. La soglia temporale dovrebbe garantire una adeguata prospettiva storica sulla quale fondare un giudizio attendibile. Ma, dov’è presente, essa varia da un paese all’altro. Inoltre è derogabile nella maggior parte delle nazioni in cui è prevista. Potremmo spiegare quest’ultima circostanza con le parole di Jan Mukařovský, secondo il quale qualsiasi norma «non può mai raggiungere la validità di una legge naturale – altrimenti vi si tramuterebbe e cesserebbe di essere norma. La norma (…) implica la pensabilità della sua violazione» (Mukařovský 1971). Questa violazione si traduce, appunto, in deroga. Già nel panorama europeo possiamo parlare di un estremo relativismo, sia per la definizione del limite temporale, sia per la sua derogabilità. Delle oltre cinquanta nazioni che ne fanno parte, solo una ventina danno del primo una formulazione normativa. Tra queste, più di dieci ne contemplano espressamente la deroga.
Questa varietà di atteggiamenti ne sottolinea il condizionamento dalle rispettive vicende storiche e la con- seguente inattendibilità sul piano critico.
In Italia non sono previste deroghe ai settant’anni statuiti dal Codice per il decreto di interesse culturale intrinseco di un’opera. Introdotti nel 2011 per le opere di proprietà pub- blica ed estesi nel 2017 a quelle di proprietà privata, i settant’anni han- no addirittura prolungato la soglia dei cinquant’anni in vigore fin dal 1902 (legge Nasi).
I beni in serie
La possibilità di individuare fattori comuni tra più opere, differenti per circostanze di realizzazione ed esiti espressivi, è riferibile al concetto di «serie» (d’Orgeix 2012) figura matematica costituita da un insieme finito di elementi non ulteriormente riproducibili (nel nostro caso, perché è defunto l’autore, oppure perché è tramontata la particolare temperie culturale o le specifiche condizioni produttive in cui nacquero determinate architetture, ecc.). Il concetto dei “beni in serie” è utilizzato da vari decenni in ambito internazionale (UNESCO), ma non nelle normative nazionali, pur potendo risultare notevolmente innovativo rispetto alla prassi ordinaria di tutela. Intendiamo il termine «serie» nell’accezione datagli da George Kubler, che lo distingue dalla «sequenza», insieme di elementi aperto ad accoglierne sempre nuovi
(Kubler 1983). Alcune opere, che chiamiamo paradigmatiche, inaugurano modalità espressive e/o costruttive inedite, in vario modo riprese e reinterpretate da quelle successive che assumono, così, carattere prevalentemente emblematico. Attribuendo a ogni opera un posto nella serie, è più agevole definirne la collocazione storica e valutarne la rilevanza artistica, rispetto a uno studio approfondito opera per opera. A seconda che l’osservatore sia fuori o dentro la successione temporale, questa gli appare come una serie esaurita o come una sequenza ancora aperta; quindi, non ancora del tutto storicizzabile. Quando giudichiamo un’opera molto recente, siamo sempre all’interno di una sequenza, mai di una serie; e siamo costretti a esaminare valori relativi piuttosto che assoluti, riferendo determinati risultati espressivi o tecnici a quelli di opere precedenti.
In una serie, la qualifica di eccellenza, invece che a una singola architettura, è estesa a tutte quelle che la compongono, ed è proporzionalmente amplificata, sia sotto l’aspetto della percezione collettiva, sia in funzione di una coerente metodologia di tutela. Si considerino, per esempio, i viadotti strallati di Riccardo Morandi. Oppure, alcune realizzazioni di Pier Luigi Nervi. Naturalmente, tutti gli elementi che compongono una serie devono risultare collegati da inoppugnabili circostanze nei vari aspetti considerati. È, pertanto, fondamentale un lavoro selettivo sulla letteratura critica, che estrapoli argomentazioni ricorrenti o inedite. La selezione delle opere va, dunque, preceduta da quella sulla loro fortuna critica. Di qui, il concetto di “rete”, in cui il riconoscimento dell’interesse di ogni elemento richiama quello di tutti gli altri, riverberandosi attraverso una “tutela d’insieme”, piuttosto che puntuale.
Da sinistra a destra: Basilica di Sant’Ambrogio, Milano (784-1098); Istituto Marchiondi Spagliardi, Milano (1953-57)
Proviamo a trasporre questi concetti in una concreta espressione che potrebbe essere accolta in una norma ad hoc all’interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «opere di architettura contemporanea a chiunque appartenenti che, singolarmente o nel loro insieme in virtù di caratteri comuni riferibili a un particolare momento culturale, a uno stesso autore, o a una specifica area territoriale, presentano interesse artistico e storico eccezionale». La fortuna critica Quanto alla letteratura critica, un esempio di come un lavoro selettivo e comparativo possa confortare il giudizio critico indipendentemente dal tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, è fornito dall’Istituto Marchiondi Spagliardi, di Vittoriano Viganò. Si confrontino le piante del Sant’Ambrogio e delle camerate del Marchiondi. In entrambi si nota la ricorrenza alternata di due sistemi strutturali, nel secondo anche sfalsati. E si leggano le parole di Giulio Carlo Argan sul primo: «Si hanno, così, due sistemi portanti incastrati l’uno nell’altro: e nella sezione dei pilastri come nella doppia ghiera degli archi appaiono ben distinte le singole forze in gioco. Il valore della forma architettonica è dunque dato dall’evidenza plastica del congegno costruttivo» (Argan 1968); e quelle di Bruno Reichlin sul secondo: «Il Convitto
(…) regge su due strutture intercalate e sfalsate: l’una (…) sopporta le parti periferiche come i blocchi sanitari (…) e i corridoi (…) mentre le camerate sono portate da una struttura interna (…). Entrambe le strutture concorrono alla particolare configurazione spaziale del convitto» (Reichlin 2009). Analogamente, la profonda spazialità dei fronti esterni, ottenuta nel Marchiondi con l’arretrare e avanzare di piani, strutture e volumi, richiama quelli di certe facciate romaniche. Le parole di Argan su quella del Duomo di Modena (1099-110) di Lanfranco sembrerebbero, per esempio, attribuibili al Marchiondi: «Il numero e la proporzione riprendono valore; ma non più per realizzare il quadrato equilibrio classico, bensì la battuta alterna, ineguale, progrediente nel ritmo. Lo spazio architettonico si definisce così (…) nel vivo contrapporsi di orizzontali e verticali» (Argan 1968). Mutatis mutandis, viene da dire: che cosa c’è di più lombardo del Marchiondi? Queste considerazioni dimostrano che un’opera del secondo Novecento può presentare caratteri comuni anche con un’opera molto più antica, che può essere parte della serie. Quanto alla possibilità di valutare criticamente un’architettura anche pochi anni dopo la sua realizzazione, Bruno Zevi (Zevi 1958), quando il Marchiondi neppure era terminato nelle finiture, parlava di «modulo lombardo» singolarmente anticipando considerazioni che hanno progressivamente stemperato il persistente riferimento al New Brutalism. Dopo solo un anno gli accenti sul simbolismo pedagogico sono anteposti da Gillo Dorfles a qualsiasi “ismo” di natura tecnica o estetica (Dorfles 1959). Nel 1966 lo stesso Reyner Banham a proposito del
- Pier Luigi Nervi, Magazzini del sale di Tortona (1949-51)